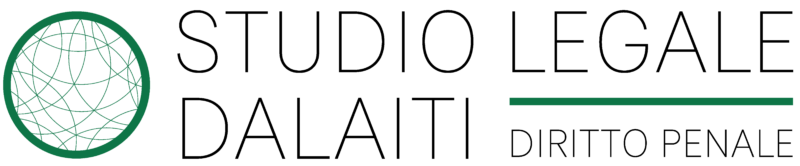Acconsentire all’acquisizione degli atti d’indagine non equivale ad accettarne gli effetti: seppur in un obiter dictum, un timido ritorno alla legalità processuale in una interessante pronuncia della Suprema Corte
Cass, Sez. IV, 16 gennaio 2020 (dep. 5 febbraio 2020), n. 4896
Sommario: 1. La vicenda. – 2. La decisione della Suprema Corte. – 3. Alcune riflessioni di sistema.
MASSIMA
«La scelta del difensore dell’imputato di acconsentire all’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti di indagine non determina la sanatoria di eventuali nullità degli stessi». Per la Suprema Corte la scelta della difesa di acconsentire all’acquisizione di taluni atti di indagine al fascicolo del dibattimento, finalizzata unicamente allo snellimento dell’attività processuale, non determina alcuna sanatoria ex art 183 c.p.p. di ipotetiche nullità e non fa venir meno il diritto di eccepirne l’inutilizzabilità.
1. La vicenda.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte coglie l’occasione per enunciare un importante principio di diritto, volto a garantire la formazione della prova nel contraddittorio delle parti secondo le regole del dibattimento. Questa, in breve, la vicenda portata all’attenzione della IV Sezione penale della Cassazione. In un processo per guida in stato di ebbrezza, durante la fase dibattimentale il difensore dell’imputato eccepisce la nullità dell’avviso di accertamento del tasso alcolemico lamentando la violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., poiché gli operatori delle forze dell’ordine intervenuti non avevano dato avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del compimento dell’atto. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale monocratico condanna l’imputato per il reato di cui all’art. 186 c.d.s., comma 7, con riferimento al comma 2, lett. c). Premesso di essere a conoscenza del conflitto giurisprudenziale in merito alla necessità che sia dato l’avviso del diritto di farsi assistere dal difensore anche in ipotesi di rifiuto di sottoporsi all’accertamento – avviso che nel caso di specie non risultava essere stato dato all’imputato – il giudice di prime cure ritiene «di aderire all’orientamento che non lo considera in tale ipotesi necessario», poiché «l’avvertimento in parola, prescritto per il compimento delle perquisizioni e degli accertamenti urgenti da parte della polizia giudiziaria dall’art. 114 disp. att. c.p.p., è funzionale alla facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia durante il compimento dell’atto in questione, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, in modo che sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini», e «poiché, in ipotesi di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, detto atto non può essere coattivamente eseguito, perde di rilievo l’assistenza del difensore e, a monte, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere».
Adita dalla difesa, la Corte d’appello di Milano conferma la sentenza di primo grado. In particolare – a fronte del motivo di gravame volto a censurare il passaggio motivazionale appena riportato – la Corte territoriale sostiene che «pur essendosi svolto il giudizio seguendo il rito ordinario e pur avendo la difesa eccepito nei termini di legge l’avvenuta omissione, è necessario evidenziare che la stessa parte appellante, all’udienza del 5 marzo 2018, aveva prestato il consenso all’acquisizione degli atti di indagine, andando quindi ad accettare gli effetti dell’atto originariamente nullo, determinandone per l’effetto una sanatoria ai sensi dell’art. 183 c.p.p., comma 1, lett. a)».
Propone quindi ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., per omesso avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del compimento dell’atto, nonché per manifesta illogicità della motivazione della Corte d’Appello nella parte poc’anzi riportata.
2. La decisione della Suprema Corte.
La Quarta Sezione della Suprema Corte rigetta il ricorso, richiamandosi all’indirizzo giurisprudenziale sposato dal giudice di prime cure, e stando al quale, ove l’automobilista si rifiuti di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico dopo essere stato sorpreso alla guida con indici di sospetta ebbrezza, «non è necessario l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p.». Tuttavia, nell’ambito di un’articolata motivazione, la pronuncia in commento riconosce la fondatezza della censura con cui la difesa aveva lamentato l’illogicità motivazionale insita nell’assegnazione di efficacia sanante ex art. 183 c.p.p. al consenso ad acquisire gli atti d’indagine al fascicolo del dibattimento. Anzitutto, viene ribadito che la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre al prelievo ematico circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia integra un’ipotesi di nullità a regime intermedio, che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado1 . Pur rifacendosi a tale consolidato orientamento, la Suprema Corte censura l’affermazione della sentenza d’appello laddove sosteneva che «pur avendo la difesa eccepito nei termini di legge l’avvenuta omissione, è necessario evidenziare che la stessa parte appellante, all’udienza del 5 marzo 2018, aveva prestato il consenso all’acquisizione degli atti di indagine, andando quindi ad accettare gli effetti dell’atto originariamente nullo, determinandone per l’effetto una sanatoria ai sensi dell’art. 183 c.p.p., comma 1, lett. a)». E ciò in quanto il processo si è svolto nelle forme del giudizio ordinario e «la scelta di una o più parti di rinunciare al contraddittorio, in relazione all’acquisizione di singoli mezzi di prova, non ne trasforma certo la natura».
Accogliendo la prospettiva della difesa, la pronuncia afferma, sia pure per inciso, che «l’acquisizione della prova su accordo delle parti è un istituto che risulta pacificamente differente rispetto al giudizio abbreviato. I due istituti infatti sono disomogenei e non assimilabili, dal momento che gli accordi che possono intervenire tra le parti, in ordine alla formazione del fascicolo per il dibattimento, non escludono il diritto di ciascuna di esse ad articolare pienamente i rispettivi mezzi di prova secondo l’ordinario ed ampio potere loro assegnato per la fase dibattimentale. La scelta della difesa di acconsentire all’acquisizione degli atti di indagine, finalizzata unicamente allo snellimento dell’attività processuale, non fa venire meno il diritto della parte stessa di eccepire l’inutilizzabilità dell’atto acquisito».
Del resto, si legge in sentenza, «in difetto di richiesta di rito abbreviato, il consenso prestato a far transitare uno o più atti delle indagini preliminari nel fascicolo per il dibattimento e ad utilizzarli ai fini della decisione, non produce alcun effetto premiale in termini di pena».
3. Alcune riflessioni di sistema.
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte coglie l’occasione per “fare ordine” circa la distinzione tra la scelta di un rito negoziale e l’acquisizione su accordo delle parti di atti d’indagine nelle forme e nei modi previsti per il rito ordinario.
Ed invero, seppur in un ampio obiter dictum, la pronuncia smentisce la decisione cui era giunta la Corte d’Appello ambrosiana, là dove, pur nell’ambito di un processo celebrato nelle forme ordinarie, equiparava – di fatto – l’acquisizione concordata ex art. 431, comma 2, c.p.p. all’istituto disciplinato dall’art. 438, comma 6-bis, c.p.p.: norma che, come noto, facendo discendere dalla scelta del rito abbreviato la sanatoria di tutte le nullità (eccetto quelle assolute), identifica un’ipotesi di acquiescenza ex lege, tale da determinare un’accettazione degli effetti dell’atto per facta concludentia.
Per la Suprema Corte, invece, «l’acquisizione della prova su accordo delle parti è un istituto che risulta pacificamente differente rispetto al giudizio abbreviato». Ebbene, il pregio della sentenza in esame sta proprio in questo passaggio, con cui il giudice di legittimità prende le distanze da un’applicazione generalizzata ed estensiva di quella «legalità degradata» introdotta con il nuovo art. 438, comma 6-bis, c.p.p. Certo: l’importante e inedito principio di diritto viene solo “sussurrato” dalla pronuncia, con un’affermazione il cui rigore garantistico resta comunque “a costo zero”, poiché privo di ricadute sull’esito decisorio. Tuttavia, la sentenza merita attenzione, anche perché suscita alcune stimolanti riflessioni attorno al comma 6-bis dell’art. 438 c.p.p.
Sebbene non abbia comportato un reale effetto innovativo, consistendo nella semplice codificazione di soluzioni cui era già pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, la disposizione ha originato numerose critiche sin dal suo ingresso nell’ordinamento. Il suo innesto, infatti, operato con la “riforma Orlando” del 2017, è espressione di un fenomeno ricorrente negli ultimi anni: sia pure ossequiando formalmente la legge, il legislatore recepisce il diritto pretorio, così, però, inevitabilmente contribuendo al tramonto della legalità. Tali “tecniche” legislative si inseriscono, poi, in un contesto fortemente condizionato dalla giurisprudenza sovranazionale, che aderisce ad un concetto di legalità molto diverso da quello proprio del nostro sistema. Ciò che però preme sottolineare è che nel panorama brevemente tratteggiato la pronuncia in esame pare mostrare un singolare paradosso.
Se, infatti, si osserva con attenzione il semplice e corretto schema logico seguito dalla decisione, si potrà notare come la Cassazione abbia scelto di abdicare all’ambiguo concetto di rinuncia presunta a far valere il vizio dell’atto. Ma se così è, viene allora naturale un interrogativo provocatorio: ammesso e non concesso che si possa aderire alla logica sottesa all’art. 438, comma 6-bis, c.p.p., non sarebbe più razionale ricondurre un effetto sanante alla scelta di accordarsi circa l’inserimento di un atto d’indagine nel fascicolo del dibattimento piuttosto che alla richiesta di giudizio abbreviato?
Con la scelta di tale rito l’imputato si limita, infatti, a rinunciare al diritto alla formazione della prova nelle forme del contraddittorio, magari in vista di uno sconto di pena, senza che la sua opzione investa il più generale profilo della conformità al modello legale delle forme del procedere. In altri termini, il reale valore di questa pronuncia è che contribuisce ad evidenziare la forzatura introdotta con il comma 6-bis dell’art. 438 c.p.p., che, sebbene non innovativo rispetto ai precedenti approdi della giurisprudenza di legittimità, si fonda, comunque, su un’equazione – quella tra scelta del rito e acquiescenza sanante rispetto alle invalidità (come pure rispetto all’incompetenza territoriale) – assolutamente eccentrica, che “prova troppo”, e che evidentemente lede il diritto di difesa dell’imputato. Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte ricorda dunque – se mai ce ne fosse stato davvero bisogno – che, in assenza di indici significativi e univoci, la volontà dell’imputato non si può presumere. Di conseguenza, pur acconsentendo all’acquisizione degli atti d’indagine al fascicolo dibattimentale, la difesa non per questo perde la propria facoltà di eccepire eventuali patologie di uno o più fra quegli atti. Ma ancor di più, questa presa di posizione dimostra come l’aver reso littera legis una sanatoria “innominata” – attribuendo un implicito consenso dell’imputato alla sanatoria di ogni invalidità processuale per il sol fatto di aver richiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato – è davvero un’operazione di dubbia costituzionalità.
Come noto, la “riforma Orlando”, se da un lato ha recepito l’orientamento ormai consolidato in materia di invalidità, ha invece superato il garantistico approdo cui era pervenuta la nota pronuncia a Sezioni Unite del 2012, che consentiva di eccepire l’incompetenza territoriale del giudice in caso di rito abbreviato sia “tipico” che “atipico”. In quell’occasione, infatti, il Supremo Collegio rammentava come, in effetti, non sia rinvenibile nel nostro sistema la regola per cui «l’imputato per poter essere giudicato dal giudice naturalmente competente debba rinunciare ai riti alternativi e, di converso, per poter accedere al giudizio abbreviato debba essere costretto a rinunciare a perseguire la legalità in tema di competenza». Ora, sebbene in quella pronuncia sia stata la stessa Corte a non volersi spingere troppo oltre (anche perché non investita della questione), affermando che «le norme poste a tutela del procedimento probatorio e dell’iter propulsivo dell’azione penale e quelle finalizzate a dare attuazione al principio del giudice naturale ad esigenze difformi e non [sono] in toto assimilabili», non pare affatto un fuor d’opera ritenere, invece, tali autorevoli e condivisibili principi estensibili anche al regime delle invalidità15. Ed in effetti, il pregio di quell’orientamento – letteralmente sterilizzato dal legislatore del 2017 e dalla giurisprudenza successiva16 – era stato quello di mettere al centro i «comportamenti della parte specificatamente indicativi della sua volontà di nulla eccepire in merito», neutralizzando così l’inaccettabile concetto di “rinuncia presunta” ad eccepire l’incompetenza per territorio. E lo stesso, dunque, dovrebbe valere anche nell’interpretare l’art. 183, comma 1, lett. a), c.p.p., che troverebbe così applicazione solo nei casi di rinuncia esplicita o quando dal comportamento della parte «possa inoppugnabilmente desumersi la rinuncia definitiva a contestare il vizio»17. La ragionata conclusione, pertanto, è che la richiesta di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato non dovrebbe poter in alcun modo essere intesa come sanatoria per facta concludentia di ipotetiche invalidità, poiché se è vero che la scelta del rito implica una rinuncia ad un accertamento del fatto nel contraddittorio (e perciò premiata con uno sconto di pena in caso di condanna), è altrettanto vero che il regime delle nullità è posto a presidio di un principio costituzionale inviolabile quale quello della conformità degli atti processuali a quanto prescritto dalla legge per la loro formazione. D’altronde, come già scriveva Beccaria, le forme «danno al popolo l’idea di un giudizio non tumultuario […] ma stabile e regolare».
Per tali motivi, paiono rimanere davvero troppi i dubbi di legittimità costituzionale del riformato art. 438, comma 6-bis, c.p.p.; dubbi che questa sentenza contribuisce senz’altro ad evidenziare. L’auspicio, quindi, è che la pronuncia in commento – che comunque ha meritevolmente posto un argine a pericolose applicazioni analogiche – possa rappresentare un primo passo verso una decisa inversione di rotta che come destinazione ha la Corte Costituzionale.